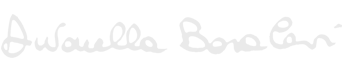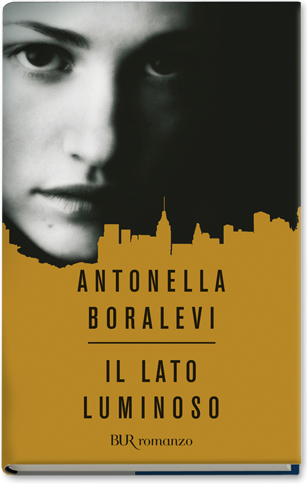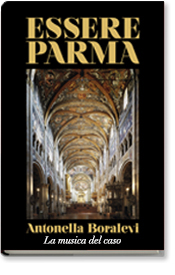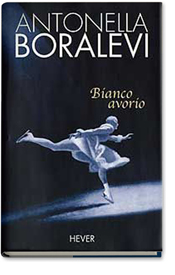PERCHÉ HA SCRITTO QUESTO ROMANZO?
Per condividere con i miei lettori una scoperta magica, che mi ha cambiato la vita.
QUALE?
Che la felicità è una musica che si suona in due. La felicità ha sempre a che fare con l’altro. Significa smettere di difendersi e aprirsi a un altro.
UN INNAMORATO?
No. Un’altra persona. Un bambino, un vecchio, un’amica, uno sconosciuto. Significa accogliere: senza nessun secondo fine. Essere uomo tra gli uomini.
LA STORIA COME LE È VENUTA IN MENTE?
Volevo un intreccio che agguantasse il lettore, che non gli permettesse di abbandonare il libro. E volevo che la felicità si aprisse come un miracolo dentro vite all’apparenza perfette, ricche di successi, eppure mangiate da un dolore che non si sa nominare. Ciascuno di noi porta dentro di sé questo nocciolo dolente, a cui non vuole pensare. E ciascuno di noi ha la possibilità di guarirlo. Ne “IL LATO LUMINOSO” il caso arpeggia i destini: e li spalanca alla luce. Può accadere dovunque, a tutti. Ho scelto New York perché è il simbolo delle infinite solitudini eppure è una città meravigliosa.
MARIA »
Cammina dentro il riflesso cangiante delle vetrine, nella luce di vetro che scontorna le facce, le disintegra come una esplosione di gas, e diventa anche lei una faccia esplosa, disintegrata in milioni di distinte particelle aguzze, impossibili da ricongiungere.
È la Quinta Avenue. È New York. È la copia esatta di esatte e nitide giornate di primo autunno, giornate che si affollano intorno all’Estate Indiana cercando di scaldarsi, sotto gli alberi del parco che di colpo invade la strada e la spenge dentro marciapiedi senza luci, solo alberghi assediati da palizzate e impalcature e cartelli sindacali, alberghi morti che diventeranno condomini di lusso.
Cammina, è un guscio vuoto, è solo la corazza che la protegge dal mondo. Questa folla la ripara. Lei vi si addentra come nel folto di un bosco, prova la sensazione precisa di quando la condussero, per la prima volta, in una vera foresta europea, nell’Alta Austria. Lo smarrimento. L’incombere pauroso degli alberi enormi, torri nere schierate a tener fuori il sole. I piccoli scarponi Meindl lasciano sull’onda del muschio una traccia impalpabile, il visino è contratto nello sforzo di seguire il passo della signorina Davies. Sotto le sue scarpe pesanti la terra si rattrappisce, scappa. Lei vorrebbe essere terra, granellini che rotolano via. Invece è una bambina, avrà sei anni, indossa pantaloni di pelle e una giacchina con bottoni d’osso. Dal piccolo viso terreo i capelli sono tirati stretti, la coda le penzola sulla schiena curva nello sforzo di farsi terra, di rientrare lei non sa dove: dentro. Ha un fermacapelli di cuoio rosso con alcune piccole mucche d’oro che si rincorrono senza trovarsi. Ha il naso che gocciola, perch´ deve essere agosto, sì: agosto, e dunque fa freddo in questa mezza montagna, dove non sa perch´ l’hanno portata, n´ quanto ce la terranno. Lei non chiede mai nulla, ha imparato che la sua vita è una cosa che riguarda esclusivamente la signorina Davies.
La signorina Davies si prende cura di lei. La fa mangiare, a dire la verità: la costringe a mangiare. Tutto. Tutte le cose repellenti e gelatinose che ingombrano il piatto che le viene messo davanti, schifosi cespugli di capelli verdastri che la signorina chiama “broccoli”, e pezzi di carne che cola via sangue, già tagliati nella misura della sua bocca. La signorina Davies la mette a letto, ogni sera, alla stessa ora, lei può calcolarla con precisione, perch´ è quando le monta dentro lo stomaco un’onda di panico, quando nella gola salgono ciuffi di cotone. La signorina Davies spenge la luce. Oh, la spenge, implacabilmente. La spenge anche se lei, Maria, ha chiesto molte volte se fosse possibile lasciarla accesa, non tanto, solo un po’, quel poco che serve a addormentare la paura, a cacciare dalla camera bianca e rosa tutti gli animali cattivi che si nascondono negli angoli e sotto il letto e dietro le tende e alcuni, lei li ha visti, lei sì, Maria, alcuni sono così grossi che ti mangiano in un boccone e hanno denti che brillano nel buio.
A occhi serrati, con la testa sotto il cuscino, il viso schiacciato contro il lenzuolo, lei, sì lei, Maria, ogni notte può sentire il respiro immenso di questi animali orribili, è una caverna che la ingoierebbe, se lei non si tenesse abbarbicata al letto, le manine strette al materasso, perché non la portino via.
Davanti a lei, verso di lei, una donna con un abito blu senza maniche, mocassini di Gucci e un minuscolo Yorkshire legato a un guinzaglio d’argento, solleva la testa come se annusasse il profumo delle vetrine di Van Cleef, socchiude gli occhi (porta grandi occhiali con lenti che cambiano il colore delle cose e le rendono azzurre, chissà se il mondo azzurro potrebbe essere più accettabile, più confacente) ed ecco, è a mezzo metro da lei, viene dritta verso di lei
MARK »
Cammina verso l’ascensore, nell’immenso pianerottolo con il pavimento di marmo verde. Marmo di Carrara, si direbbe. Una palude verdenera in cui i suoi piedi perfettamente calzati di impeccabili mocassini italiani avanzano un passo dopo l’altro, attenti a non farsi ingoiare. Servirebbe il bastone di osso: che non ha. Il posto del bastone inglese di osso è a casa, nell’anticamera, dentro la potiche di epoca Chien Lung, accanto agli altri bastoni della collezione, un gregge di manici d’argento che sono cani da caccia e lupi e teste di cervo. Quando per caso se ne urta uno, gli altri si muovono tutti insieme, gridano una canizza di tintinni, ciascuno legato al destino del vicino. Senza scampo.
Chiama l’ascensore. L’operazione gli risulta complicata, non per l’età che ha, sessantotto anni, ma perché i pulsanti sono di perspex trasparente e in questo momento ha la vista annebbiata, benché ci veda benissimo, d’abitudine. Sono gli altri che portano gli occhiali.
È New York, è la First Avenue, 400/1882 East. Persino il pianerottolo ha larghe finestre, in questo edificio da poco rinnovato. La vista della sala d’aspetto è indubitabilmente migliore: sul Franklin D. Roosevelt Drive, attraverso un parco tagliato a semicerchio che occupa l’intero isolato e libera lo sguardo fino all’Harlem River e allo sputo verde del Mill Rock Park, dimenticato nel mezzo da un creatore distratto. Chissà dove guardava, il Creatore qualche minuto fa, qualche decina di metri fa, mentre lui era seduto sulla poltroncina da teatro di velluto rosso davanti alla scrivania del dottor Mathison.
L’infermiera del dottor Mathison ha l’aspetto della brava massaia dello Yorkshire, anche se probabilmente lo ignora e nemmeno sa che esiste un luogo del mondo denominato “Yorkshire”. Capita così, ancora, a questa gente che crede di essere americana e invece si porta dietro attraverso le generazioni le stesse facce di burro rosa, stantie e nude, che abitano nelle casette a schiera delle periferie della vecchia Inghilterra, o dell’Irlanda, o dell’Olanda. Facce che sbarcarono con i loro stracci fradici di speranza nelle prigioni d’attesa di Staten Island e che adesso appartengono a infermiere nello studio di lusso di un medico alla moda o a stripteaseuses del Village, indifferentemente. Dio non gioca a dadi. O forse sì. Non ha appena buttato sul tavolo la sua giocata? L’ascensore gli si spalanca davanti all’improvviso. La punta del mocassino italiano incespica per un attimo nella fenditura tra la piattaforma e il pavimento del pianerottolo. Deve aggrapparsi di lato, all’angolo metallico della porta. Mentre l’ascensore scende, sedici piani di fila, nessuna sosta intermedia, una discesa inarrestabile, stabilisce che è il caso di ricomporsi, non tanto per Rufus, ma per sé. Si slaccia i primi tre bottoni del cappotto di cachemire blu scuro, stende con cura i due lembi della sciarpa di vikuna immacolata, sistema il bordo soffice intorno al collo seguendone l’orlo con la punta dell’indice e del pollice. È così che gli si forma nella mente una immagine ridicola: la sciarpa è un cappio. Tra breve, tra quanto? Il boia butterà di lato lo sgabello e il nodo scorsoio farà il suo dovere.
Finalmente esce nel sole, il sole idiota dell’Estate Indiana, incapace di distinguere una stagione dall’altra.
Rufus c’è, naturalmente.
BINKY »
Mio Padre. Mio scoglio. Mio padre sullo scoglio. Nei giorni di sereno respiro disperazione.
Quella volta che mio padre stava in piedi sullo scoglio del deserto sopra la piscina degli adulti nel ranch accanto ai pozzi dove la famiglia custodiva i soldi di petrolio con i camerieri in guanti bianchi. Quella volta che mio padre aveva un costume nero, di materiale poroso, gommoso, a toccarlo. Quella volta che aveva addosso un costume fatto a pantalone corto che gli usciva il muscolo della parte alta della coscia come un dito da un guanto senza dita e una lunga canottiera da operaio, a mio padre piaceva travestirsi da operaio, ma era un operaio Cole of California, comprato da Henry Bendel’s sulla Quinta Avenue piano interrato prego certo Signore al Suo Servizio Signore Buona giornata Signore, costava centocinquanta dollari nel 1953 la canottiera per essere un operaio uguale a tutti gli altri operai di Henry Bendel’s. Quella volta nell’estate del 1953 che sembrava uguale a tutte le altre estati e a tutti gli altri inverni, la piscina di Palm Beach per l’estate e il camino del Vermont per l’inverno; quella volta che c’era mio fratello Bor con la macchina fotografica e mio padre aveva allargato le braccia e stava per spiccare il volo librarsi su tutti noi, piccolo popolo festante, minuscolo popolo, spilli di teste confuse, nere, sempre più fitte, sempre più lontane, vola vola vola vola.
Vola via Papà.
Bello era bello era mio padre. Era il Generale Inverno Era Tyrone Power Era un casanova d’argento. Una moneta di padre. Una nave di dollari di padre. Una larga faccia lunga bionda. Più bionda dei capelli, perché i capelli davano sul rame delle miniere di rame con le sfumature necessarie a ogni rispettabile famiglia wasp, quelle famiglie che diventano ancora più rispettabili quando si trasferiscono da Baltimora a Park Avenue perché sono state innaffiate di petrolio.
Sul camino del ranch nel Vermont c’era un quadro dipinto a olio. Una montagna lunga sullo sfondo e in primo piano un cowboy a cavallo davanti a tre vacche quattro vacche cinque perché una era quasi fuori dal quadro e cercava chissà che cosa: erba, ecco: erba. Anche lei cercava l’erba. Brava vacca. Fatti un tiro, vacca. Sei una vacca, Binky. Ma questo non me lo ha mai detto nessuno, nemmeno le voci me l’hanno detto. Io sono un fungo. Guarda come mi disintegro. Sono il fungo di Bikini. Correte ragazzi che il sole è nero è giallo è rosso la polvere è nera è gialla è rossa correte forte che finalmente si muore.
Davanti al camino del ranch del Vermont c’erano due divani. Uno marrone/rosso scuro fatto come una mezza tazza di tè. Una tazza di tè. Voglio bere una tazza di tè. Ancora un sorso. Un sorso. Puah. Questo tè sa di materiale poroso, gommoso, a toccarlo. L’altro divano era a fiori. Un saggio divano a fiori rossi e marroni. I cuscini di questo divano erano molto cattivi e c’erano tutte quelle domestiche che li sbattevano tump tump tump e li facevano gonfi gonfi come la pancia dei cervi che mio padre ammazzava (mio padre ammazzava cervi e bambini) e quando ti sedevi il divano diceva che non poteva proprio sopportare che tu ti fossi seduto lì a infastidire e ti faceva scivolare giù: così cadevi per terra ma il tappeto era morbido, pelo morbido di agnello o di lupo, non fa differenza. Agnelli di lupo.
Quella volta che mio fratello Bor fotografò mio padre sullo scoglio nel deserto accanto alla piscina degli adulti e mio padre allargò le braccia e sembrava un disegno.
Quella volta che mio fratello Bor fotografò la famiglia, tutta la famiglia, seduta intorno al camino del Vermont che era stato acceso tutto il giorno e aveva consumato tutte le foreste intorno per quel poco di calore indispensabile ai caloriferi che andavano a tutto kerosene e bollivano senza scaldare il cervello.
Si vedono: da destra: mio padre con la giacca nera da sera e la camicia bianca e il papillon nero che tiene il braccio sinistro intorno a mia sorella Vi che ha un vestitino a roselline di bosco di vikuña e i capelli molto chiari e la frangia e il braccio di mio padre sembra che abbracci lei invece sostiene il libro rigido di cartone rigido che sta leggendo a lei o per lei o per noi, questo non c’è nella fotografia. Le fotografie hanno questo, di bello: lasciano il campo libero. Tu credi di vedere quello che è stato messo nella fotografia, lavorato nella camera oscura, stampato su carta Kodak, infilato in una busta con l’asola per la striscia oscura dei negativi che nessuno utilizzerà mai più. E invece no, bello. Tu vedi quello che ti pare. Vedi tuo padre che abbraccia tua sorella e invece tuo padre regge un libro. Il vantaggio della fotografia è che, lo sai, è un imbroglio. Nella vita quotidiana invece ti fregano come gli pare. Per dire: tu esci di casa e vedi sul marciapiede di fronte la tua amica Holly e attraversi per andare a salutarla ma passa il numero 67 e tu finisci spiaccicata come un topo sotto la ruota anteriore destra mentre i passeggeri vengono sbattuti come uova uno dentro l’altro nella scodella per la maionese che è l’autobus. E tu non potevi sapere che sarebbe finita così. Altrimenti non avresti attraversato. O forse avresti attraversato ma allora perché l’autobus ti stava facendo un piacere a metterti sotto, che è una cosa diversa. Il vantaggio della fotografia è che ci puoi mettere dentro quello che ti pare e che ci puoi vedere cose diverse nel momento in cui la guardi, ogni volta che la guardi. È il servizio segreto della vita invisibile.